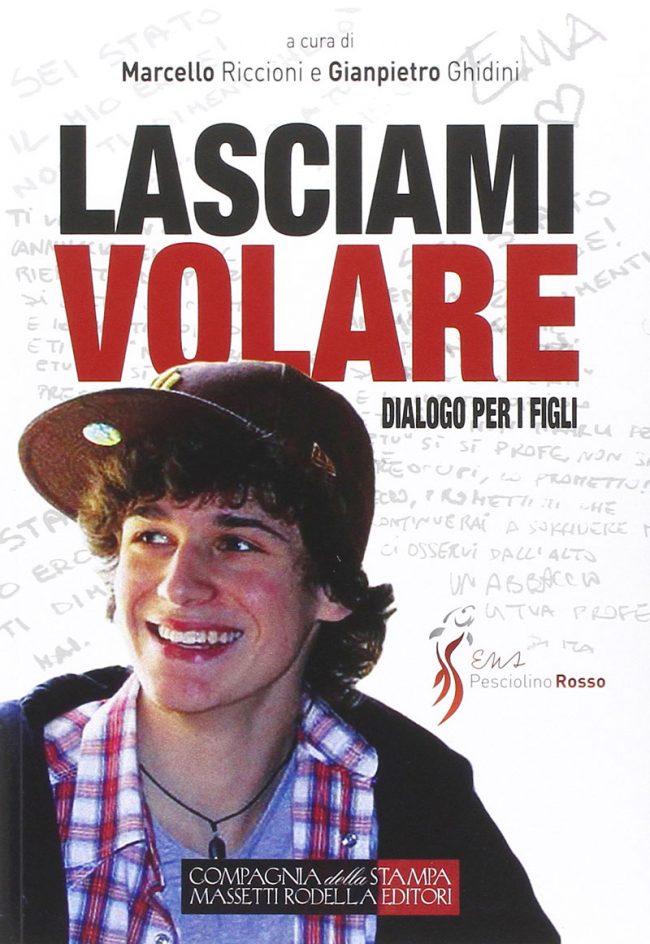La figura paterna tra autorità e identità nello spettacolo geniale di Gabriele Lavia
Appena entrati nella platea del Teatro Quirino di Roma, dove è in scena fino a domenica Il Padre di August Strindberg con la regia di Gabriele Lavia, si viene inondati di certezze. Intanto si sa per certo che si assisterà a una grande prova di uno degli ultimi mattatori del panorama teatrale italiano. Poi si osserva la scenografia, a sipario aperto, e tutto, ancor prima che personaggio appaia o che battuta venga proferita, è già esplicito e lapalissiano: i segni della stortura e disfacimento sono ovunque. Libri confusamente accatastati per terra, tutto è inclinato come sull’orlo di un precipizio, il pendolo pende, sedie e poltrone azzoppate e ad avvolgere quinte, fondale e palco il “rosso Lavia”, come si diceva una volta, ma non quello della passione stavolta, bensì del sangue che ha invaso il mondo come nella scena di un crimine di un efferato omicidio. E infine come in una sorta di trance premonitrice, prima ancora che si faccia “mezza sala” e poi buio, sembra già di udire quella colonna sonora che fonde violini cupi e ineluttabili con impetuosi fenomeni metereologici e di vedere il “roscio maledetto”, come da giovane i suoi invidiosi detrattori lo appellavano, strisciare per terra vittima di tragiche e convulse emozioni. Facile veggenza. Infatti di lì a pochi istanti immancabilmente giungono le conferme: «il mondo è strano» si dice in avvio e poco dopo «la morte non fa danni a un mondo in rovina» si canticchia in una filastrocca. Inesorabili poi arrivano i violini e la bufera. Della saga delle certezze fanno parte anche i caratteri dei protagonisti che non vivono alcuna parabola evolutiva.
Partiamo dal padre, il capitano Adolf, Lavia per l’appunto: è vero che vivrà un calvario che lo porterà alla follia con la mente minata e rosa dal dubbio sulla sua paternità, raggirato e privato di ogni autorità e identità, ma sin dai primi passi in scena è malfermo, dà segni di smarrimento e ha l’aurea della vittima predestinata. Poi c’è Laura, Federica Di Martino, la moglie che non accetta che sia il marito a decidere il futuro dell’educazione professionale della figlia e ordisce l’impietosa, ingannevole e fatale trappola di cui sopra. Anche qui non c’è successione emotiva e la sua figura appare subito algida, glaciale, perfida e spietata.
Tutto quanto è noia allora? Assolutamente no. Impareggiabile infatti è Lavia nel danzare nella terra desolata. Ti prende per mano e ti porta tra le macerie dei rapporti familiari, nell’egoismo di chi considera i figli protesi di se stesso, nell’intimo strazio dell’uomo umiliato senza più ruolo e dignità. Geniale infine il regista nel disseminare lo spettacolo di intramontabili evocazioni drammaturgiche: la moglie Laura sembra Jago nel modo di instillare dubbi e avvelenare l’anima; il capitano-padre nello stupefacente quadro finale sovrastato dall’imponente scenografia rossa urla come il Re Lear impazzito nella foresta; entrambi, marito e moglie, si dilaniano in una resa dei conti alla stregua di George e Martha in Chi ha paura di Virgina Woolf?; i reiterati «è pazzo!» risuonano come nel finale del Berretto a sonagli di Pirandello.
Alla fine di questa odissea si naufraga nell’annichilimento del protagonista e si lascia il teatro con un solo dubbio: troppo Lavia? La risposta nelle parole di Strindberg: «Io conosco solo me stesso e non posso che parlare di me!».
di Michele Sciancalepore, fonte Avvenire
31 Gennaio 2018